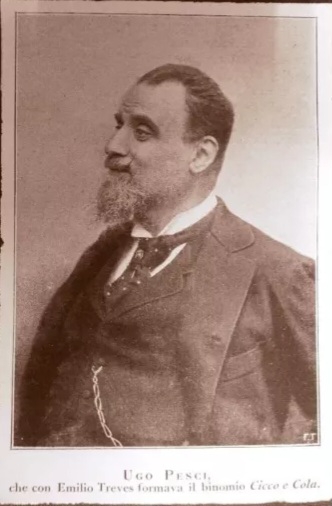La Brigantessa
domenica 19 gennaio 2025
Il giornalista e l'ultimo brigante
venerdì 2 settembre 2022
Termine o Cippo di Confine - Storia e diffusione in Italia
Con cippo di confine si intende un segnale che indica il confine tra due stati.
Normalmente il cippo è realizzato con pietre o pali; i cippi indicanti gli armoriali di due paesi limitrofi recano incisioni su rocce inamovibili. Oltre all' armoriale in genere riportano anche l'anno di collocazione del cippo e il suo numero d'ordine. Al di sopra del cippo a volte un solco indica il tracciato del confine. Al di sotto del cippo invece vengono spesso interrati testimoni di confine (ad esempio cocci marcati con appositi segni) con la funzione di verifica della collocazione originaria del cippo nel caso di una sua rimozione.
I cippi terminali sorsero in età romana come confini tra proprietà e "furono rivestiti di valore sacrale. In tal senso vanno considerati i Terminalia, le feste che si celebravano il 23 febbraio dedicate al dio Terminus"; a loro tutela il diritto romano predisponeva un'apposita formula di giudizio, l'actio finium regundorum.
I cippi in epoca moderna cominciarono a diffondersi, come segni di confini tra Stati, a partire dal XV secolo; in ambito urbano, comunque, i cippi continuarono ad esercitare un ruolo di confine amministrativo per tutta l'età successiva.
La storia dei termini o cippi di confine si perpetua nei secoli e troviamo anche dei documenti che testimoniano come avveniva la misurazione dei confini e l’installazione dei cippi a definirlo.
Il documento è una serie di disegni di un “agrimensore” francese (quelli con il cappello rosso sono gli agrimensori dei due confinanti gli altri sono semplici “aiutanti” ) [Bertrand Boisset]
L’escursionista Gianluca Diana in una sua passeggiata nel bosco di Subiaco ne fotografa uno molto particolare. Esso presenta lo Stemma benedettino abbaziale (XVII sec) ed indica il Rettoraggio di Santa Scolastica riprodotto sui cippi di confine : questi cippi sono la testimonianza storico-archeologica che riguardano il complesso tema territoriale del Rettoraggio attraverso i secoli.
Il monastero di Santa Scolastica di Subiaco, all'origine dell'abbazia territoriale omonima, fu uno dei tredici monasteri fondati da san Benedetto da Norcia nella prima metà del VI secolo nel territorio sublacense.
Fondamentale per la conoscenza della storia del monastero e delle varie esenzioni e privilegi di cui fu dotata è il Regesto sublacense. Dopo la distruzione ad opera dei Saraceni, il monastero dei santi Benedetto e Scolastica (oggi Santa Scolastica) fu ricostruito e ottenne da papa Leone VII le prime proprietà e soprattutto, il 29 maggio 939, l'esenzione dalla giurisdizione episcopale. Un'ulteriore concessione fu data dall'imperatore Ottone I l'11 gennaio 967, in base alla quale l'abbazia sublacense ottenne l'immunitas su una serie di terre e castelli di sua proprietà, diventando così uno stato autonomo nel contesto del Sacro romano impero; l'autonomia temporale perdurò fino al 1753.
«Un altro documento importante del Regesto è il privilegio di Giovanni XVIII (1004-1009) del 21 luglio 1005, con cui venivano confermati i possedimenti e i diritti dell'abbazia ed erano sottratti ai poteri d'ordine del vescovo diocesano non solo il monastero, ma anche le chiese rurali. Quindi si può parlare di abbazia nullius solo per il monastero e le chiese incorporate a esso. Il privilegio venne confermato anche da Leone X (1049-1054) nel 1051.»
“La necessità di definire i limiti della sfera di giurisdizione del monastero Sublacense di S. Scolastica è stata nel tempo variamente sentita.
G. P. Carosi sciolse il nodo della definizione politica dei possedimenti dell’abate di Subiaco tra X e XIII secolo.
Dal privilegio di Ottone I del 967,i possedimenti del monastero di Subiaco furono infatti considerati immuni dal controllo di qualsiasi potere esterno. L’abbazia territoriale di Subiaco alla pari delle diocesi confinanti, aveva suoi terminainterni ed il confine nord del suo territorio corrispondeva alla divisione tra Terra Sancti Petri e territorium Marsicanum”
da I CONFINI DEI POSSESSI DEL MONASTERO SUBLACENSE NEL MEDIOEVO (SECOLI X-XIII) di Paolo Rosati
https://www.academia.edu/5144437/I_confini_dei_possessi_del_monastero_sublacense_secoli_X_XIII_
Ma abbiamo altri esempi di termine di confine nel teritorio italiano :
Il Termenù e i cippi di confine (Riccomassimo)
A metà del Settecento, durante il governo dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, venne definito il confine tra l’Impero austro-ungarico e la Repubblica di Venezia. In seguito al trattato di Rovereto del 31 agosto 1752 vennero precisate anche le proprietà dei Lodron, costretti ad abbandonare il Pian d’Oneda, dietro pagamento di un’ingente somma da parte della comunità di Bagolino, a favore della quale il Comune di Storo firmò un’impegnativa fideiussione con l’approvazione imperiale.
Lungo
il confine vennero posizionati grossi cippi di granito contrassegnati
da lettere progressive dell’alfabeto e numerati. Ne sono rimasti
solo due.
Il cippo più noto (Termenù) si trova a Riccomassimo,
nel podere di Gilberto Lombardi, ed è contrassegnato n. 1 A 1753.
L’altro è a Baitoni, 400 metri oltre la passerella sulle rocce, a
sud del ristorante Miralago, lungo un sentiero che segue la costa del
lago. È monumentale, alto quasi due metri, e ha scolpite su entrambe
le facciate la scritta n. 6 F 1753. Sui lati nord sud ci sono due
nicchie rettangolari che dovevano contenere rispettivamente l’effige
bronzea dell’imperatrice e il leone veneziano di S. Marco.
Un
altro segno del medesimo confine è scolpito nella roccia lungo il
“Sentiero dei contrabbandieri. Dopo una decina di minuti di
cammino, si vede incisa nella roccia (evidenziata da un segnale
turistico) la data 1753. Di qui la linea di confine proseguiva poi
verso la Valle di Vestino, dove altri cippi, fino al numero 36, sono
stati rinvenuti e intelligentemente recuperati.
Altre colonne in
granito si trovano lungo il lato nord di via Campini e sulla costa
trentina del lago d’Idro presso la foce del Caffaro; alcune sono
marcate 1882, altre 1885; segnavano il confine fra Italia e Austria;
sui lati contrapposti, a nord e a sud, sono incide le lettere A
(Austria) e I (Italia). Un alto cippo di granito, datato 1876, è
collocato adesso nel parco giochi di Baitoni, un altro ancora lungo
la provinciale Storo-Baitoni, con la data 1869.
Testi elaborati dall'associazione Il Chiese, materiale fotografico fornito da Lodron Fotoclub
Abbiamo poi quest'articolo di recente pubblicazione :
Trovato rarissimo cippo pomeriale in Piazza Augusto Imperatore: posizionato da Claudio nel 49 d. C. per delimitare i confini di Roma.
Lo hanno trovato vicino all'allaccio del collettore fognario, interrato e in parte danneggiato, ma subito si sono accorti che la scoperta era eccezionale: il cippo pomeriale in travertino rinvenuto durante i lavori di rifacimento di piazza Augusto Imperatore era stato posizionato dall'imperatore Claudio nel 49 d. C. per segnare il confine tra la città di Roma e l'ager (il territorio esterno).
Fu lui che, dopo la conquista della Britannia, decise di estendere i limiti dell'antica Urbe conferendole un nuovo limite sacro, civile e militare. Quando è stato ritrovato un mese e mezzo fa era in piena falda acquifera e non poteva essere lasciato sottoterra. Così, per renderlo visibile a tutti, è stato portato nella sala Paladino del museo dell'Ara Pacis e prossimamente sarà valorizzato all'interno del Mausoleo di Augusto.
"Si tratta di un nuovo importante tassello della Storia di Roma - ha spiegato la Soprintendente speciale Daniela Porro durante la conferenza stampa all'Ara Pacis - il pomerio era il recinto sacro in cui non si poteva entrare armati né fare sepolture. L'allargamento del pomerio era una decisione politica e religiosa molto importante e delicata contro cui si scagliò il Senato".
Claudio ebbe la meglio e questo atto si inseriva in una politica più ampia dell'imperatore: infatti aveva il proposito di allargare la cittadinanza anche alla Gallia (dove Claudio era nato). Voleva tornare a una visione multietnica e inclusiva di Roma così com'era al momento della sua fondazione. Ma i senatori si opposero, convinti che la cittadinanza spettasse solo agli italici: era già in atto lo scontro tra i sostenitori dello Ius Sanguinis e dello Ius Soli.
"Dunque l'allargamento del pomerio - continua Porro - aveva un preciso significato simbolico ma era anche funzionale ad accogliere nuovi cittadini".
Prima di questo cippo, l'ultimo è stato ritrovato 100 anni fa e rispetto agli altri si è conservato quasi interamente nelle sue originali dimensioni: misura 193 centimetri di altezza per 74,5 di larghezza per uno spessore di 54 centimetri.
Solo la parte superiore, una ventina di centimetri, manca. Il direttore dei Musei capitolini, Claudio Parisi Presicce, ha spiegato che nella parte mancante era stata incisa la prima parte dell'epigrafe che in tutto conta nove righe: vi era riportato il nome di Claudio e le sue cariche, compresa quella di Censore che gli ha permesso di modificare i confini pomeriali.
Poi, ancora visibile, la spiegazione di quell'allargamento: "Auctis popoli romani finibus". Ovvero: "Perché è stato ampliato il territorio del popolo romano".
Claudio era un imperatore molto particolare, avrebbe voluto studiare e ricostruire l'antica tradizione etrusca: addirittura introdusse alcune lettere che risalgono alla tradizione etrusca. Sono presenti nel cippo e questo rende la scoperta ancora più interessante, un racconto marmoreo della sua volontà di includere diverse civiltà. "Roma non smette mai di stupire e si mostra sempre con nuovi tesori", ha concluso la sindaca Virginia Raggi.
Termine di confine dei Malaspina a Giovagallo
Tra le tante cose antiche, che si incontrano nei boschi della Lunigiana, ce ne sono alcune che mi affascinano tanto: i termini o cippi di confine.
Essi possono avere diverse funzioni: delimitare,
fissare la direzioni, determinare i confini, ricordare un qualcosa.
Solitamente sono fatti in pietra arenaria e possono avere varie
forme. Riportano spesso simboli, date, linee e, a volte, ci dicono
tante cose di un luogo.
Ovviamente hanno un ruolo importante
nello studio della storia, perche ci indicano con certezza il confine
dei feudi. Inutile dire che nell'antichità, erano importantissimi e
salvaguardati. Nello statuto della comunità di Terrarossa (libro 5º
Cap.XI) si legge: "Chi con mala intenzione per usurpare i beni
altrui confini di se, et de sua confinanti removerà termini sia
punito per ciascuna volta e per ciascun termine a lire dieci e di più
a rimetter in detto luogho detto termine".
Tra i cippi più
belli che ho trovato, ci sono sicuramente quelli di Giovagallo. In
particolare due, di forma e dimensione identica, posti a pochi metri
l'uno dall'altro. I due cippi si trovano su un’ ampia strada di
terra, verosimilmente trafficata fin dai tempi antichi.
Il primo
cippo (quello delle prime foto in basso), presenta un solco sulla
parte superiore. Da un lato largo, ha una riga centrale con delle
righe laterali che partono da quella centrale.... purtroppo è molto
consumato, ma osservandolo da vicino si può notare che il disegno
ricorda lo stemma dei Malaspina dello "spino secco”. L'altro
lato presenta delle linee scolpite, quasi a formare una riga
terminante in due frecce (<---→). Ha una particolarità
interessante: è molto consumato al centro, in senso orizzontale. Ci
siamo chiesti il motivo e siamo arrivati ad una conclusione molto
plausibile: quelli sono i segni di una corda che per anni ha
consumato la pietra. Magari corde che servivano a legare dei cavalli
o degli animali da tiro, magari in un momento di riposo, dopo aver
fatto molta strada.
L'altro presenta una grande V sul lato
largo, posto ad ovest. Questo fa supporre il che la V indichi il
feudo di Veppo. Sul lato opposto (quello ad est) c'è scolpita una
grande T che, quasi certamente, indica il feudo di Tresana. Sui lati
stretti presenta: da un lato la data 1563, mentre dall'altro una
croce. Il tutto è visibile nelle foto sotto.
Purtroppo,
quest'ultimo cippo è stato rubato e quelle postate, forse sono le
uniche foto esistenti, fatte molto tempo fa. Per questo motivo, non
posso indicare pubblicamente su internet, il luogo dove si trova il
cippo "superstite". Inutile dire che se vi dovesse
succedere di vederlo in qualche giardino, provvedete immediatamente a
fare denuncia, visto che queste persone stanno rubando la nostra
storia.
Cippi di confine nell’Appennino tosco – emiliano
Percorrendo il crinale di confine tosco - emiliano - Province di Parma e Massa Carrara, ci si imbatte in parecchi cippi in pietra arenaria, messi a dimora nell'anno 1828 per delimitare la linea di confine tra il Ducato di Parma ed il Gran Ducato di Toscana.
I "termini" originariamente collocati erano in numero di 123, come si evince dalla seguente:
“Raccolta
Generale delle Leggi per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla –
Disposizione Presidenziale che pubblica l’atto finale del
collocamento de’ termini lungo la linea di confine tra gli Stati di
Parma e quelli di Toscana. Parma, 7 Gennajo 1829”.
Atto
finale del collocamento dei termini nella linea di confine, tra il
Ducato di Parma e il Gran Ducato di Toscana. Processo verbale
dell’apposizione dei termini, di confine sulla linea dell’Appennino
tra il Ducato di Parma e il Gran Ducato di Toscana. L’anno mille
ottocento ventotto, questo dì quattordici Ottobre.
Essendo che colla Convenzione fatta in Firenze il ventisette Novembre 1824 fossero combinate le vertenze giurisdizionali vigenti già sopra alcuni punti della linea dividente i Dominj Parmigiano e Toscano sull’Appennino; e fosse convenuto che le Commissioni da nominarsi per l’apposizione dei termini, e per ogni altra misura diretta ad assicurare la piena e perpetua osservanza degli articoli concordati, passerebbero un atto contenente la descrizione delle operazioni eseguite, nonchè le condizioni, e dichiarazioni di natura di simili atti....(omisis)
Termine
n.° 121 posto
come sopra sul crine del Monte luogo detto la Nuda di Iera a lato
della strada che conduce a Iera suddetta venendo dal Parmigiano
(secondo di triplice confine), ove ha fine il Dominio Estense col
suddetto Territorio di Treschietto e ricomincia il Bagnonese Toscano,
proseguendo sempre il Parmigiano col Comune di Monchio, distante dal
precedente pertiche fiorentine 1987, pari a metri 5656 e cent.
04.
Termine n.° 122,
posto come sopra sul crine del Monte, luogo detto Bragolata o Losura,
(terzo di triplice confine), ove abbandonato nuovamente il Toscano,
torna l’Estense col Territorio di Varano, ed il Parmigiano col
Comune di Monchio, distante dal precedente pertiche fiorentine 193,
pari a metri 578 e cent. 16.
Termine
n.° 123,
posto come sopra sul crine del Monte nella Foce, luogo detto
Branciola o Sella (quarto di triplice confine) ove lasciato
l’Estense, incomincia il Toscano col Territorio Fivizzanese,
seguitando sempre il ridetto Comune di Monchio Parmigiano, distante
dall’antecedente pertiche fior. 870, pari a metri 2,540 e cent.
40.
Queste
notizie le ho prese dal seguente
sito:
http://www.lavocedimonchio.it/Microsoft
... 0Tosco.pdf
è
molto interessante e, oltre alla ricerca ed alla descrizione dei
cippi di confine, contiene narrazioni sul contrabbando del sale, sui
mercati , su letali traversate invernali, su controversie per la
pulitura di strade dalla neve, (metà 1700 e fine 1800)
Nella
parte iniziale (Nord - Foce dei tre confini) e (Sud - Monti Bocco e
Malpasso - zona Passo del Lagastrello) si trovano cippi di confine
anche fra gli Stati di Parma e Genova (GE), fra Toscana e Genova
(GE), a Nord, e fra Parma e Modena ed uno fra Modena e Lucca.
Infine
nella zona del Passo del Cerreto si trova ancora un termine di
confine dell' Empire Francais napoleonico.
Concludo con i Cippi di Confine papalini/borbonici tanto noti nel nostro territorio
Un confine lungo tredici secoli quello tra lo Stato Pontificio ed il Regno delle due Sicilie. Non riuscendo a stabilire l’esatto confine per gestire le risorse del territorio, finalmente venne sottoscritto a Roma, il 26 settembre 1840, un trattato che tra l’altro prevedeva l’installazione di 686 Termini di confine numerati progressivamente dal mar Tirreno al mar Adriatico (la numerazione effettiva va da 1 a 649 perché alcuni Termini hanno lo stesso numero seguito da una lettera alfabetica maiuscola).
 |
chiavi di Pietro |
 |
| medaglia di confine 1840 |
L’ installazione dei cippi iniziò effettivamente nel 1846, il N° 1 si trova a Terracina.
Nel territorio di Sonnino si trovano tutti in ambiente montano, attraversano quel confine naturale che sono i Monti Ausoni e sono in totale 16 di cui 13 ancora integri.
Alcuni cippi già in passato vennero quasi subito divelti per rubarne la cassetta in legno sepolta alla loro base con all’interno una medaglia commemorativa.
Gran parte dei cippi sono dovuti esser riposizionati, dei tre mancanti sulle cime del confine di Sonnino non se ne hanno traccia.
La fortuna dei cippi ebbe breve durata, da li a pochi decenni dalla loro installazione l’antico confine venne cancellato con l’unità d’Italia.
Termini o cippi di confine nel territorio di Sonnino
N 18 Cima Monte Romano (assente)
N 19 Spregatora di M. Romano
N 20 Cisternone
N 21 Cavuto delle Terre di S. Pietro
N 22 Pero Ciavolone 1°
N 23 Pero Ciavolone 2°
N 24 Lo Peschio
N 25 Monte Ceraso
N 26 Il Cavallo
N 27 Cisterna Maleccia
N 28 Serra del Conte
N 29 I Cima di Monte Tavanese
N 30 II Cima di Monte Tavanese (assente)
N 31 Cima della Serra Tavanese
N 32 Serra Tavanese
N 33 Monte delle Fate (assente)
 |
N 18 Cima Monte Romano |
 |
N 19 Spregatora di M. Romano |
 |
N 20 Cisternone |
 |
N 21 Cavuto delle Terre di S. Pietro |
 |
N 22 Pero Ciavolone 1° |
 |
N 23 Pero Ciavolone 2° |
 |
N 24 Lo Peschio |
 |
N 25 Monte Ceraso |
 |
N 26 Il Cavallo |
 |
N 27 Cisterna Maleccia |
 |
N 28 Serra del Conte |
 |
N 29 I Cima di Monte Tavanese |
 |
N 30 II Cima di Monte Tavanese |
 |
N 31 Cima della Serra Tavanese |
 |
N 32 Serra Tavanese |
 |
N 33 Monte delle Fate |